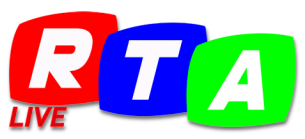A cura della Camera Civile di Nocera Inferiore

La tematica in esame deve, necessariamente, muovere dalla attuale considerazione del diritto all’oblio, ossia del diritto a non restare esposti a tempo indeterminato alle conseguenze dannose che possono derivare al proprio onore e alla propria reputazione, da fatti commessi in passato o da vicende nelle quali si è rimasti coinvolti e che sono divenuti oggetto di cronaca. Orbene, il diritto all’oblio risponde all’esigenza che ognuno di noi può avere a far dimenticare alla collettività la propria identità, in merito a circostanze e fatti specifici in cui è stato coinvolto, in merito ai quali non sussiste più un reale, concreto ed attuale interesse pubblico ad identificare un determinato soggetto, a causa ed in conseguenza del notevole tempo trascorso. Per meglio comprendere l’attuale significato che oggi viene riconosciuto al diritto all’oblio è opportuno ricordarne l’evoluzione storica.Tale diritto si può storicamente fare coincidere con la nascita del diritto alla privacy ed alla riservatezza, già iniziato a diffondersi nell’800, ma è con l’avvento dell’era digitale e dei social network che, relativamente alla tutela dei dati personali, lo stesso acquista maggiore valenza.
Si parla di diritto all’oblio, in relazione a tre differenti situazioni. La prima è quella di chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un notevole lasso di tempo tra la prima e la seconda pubblicazione; la seconda, relativa ad internet, risponde all’esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale (Cass. n. 5525 del 2012) e, infine, la terza, che si verifica quando l’interessato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati (Corte di giustizia U.E., n. 131/12, Google Spain). Il diritto all’oblio si colloca, per quanto innanzi, nell’ambito della disciplina giuridica della protezione dei dati personali, che, negli ultimi vent’anni, è stata oggetto di importanti interventi normativi, dapprima, con la Direttiva UE n. 46/95, che indirettamente faceva riferimento a tale diritto all’oblio e, successivamente, con la nuova disciplina europea, espressamente riferita alla privacy, ossia con il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), che ha finalmente introdotto una norma apposita sul diritto all’oblio, affermandone definitivamente la positività.
Il diritto all’oblio è stato consacrato nell’art. 17 del GDPR e il legislatore comunitario lo ha fatto coincidere con il diritto alla cancellazione, applicabile nei casi elencati dalla norma suddetta (art. 17, comma 1 del GDPR). Tale diritto all’oblio, come statuito dalla recente normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali, trova applicazione in diversi casi: quando i dati non sono più necessari, rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti; quando l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati personali; quando l’interessato ha esercitato il diritto di opposizione al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento e quando l’interessato si oppone al trattamento per finalità di marketing diretto, inclusa la profilazione. Ulteriori casi in cui il suddetto diritto trova applicazione si verificano quando i dati personali sono stati trattati illecitamente o i dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, cui è soggetto il titolare del trattamento; ancora, quando i dati personali sono stati raccolti, relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione, e trattati sulla base del consenso di un minore, laddove il minore abbia almeno 16 anni di età, o del consenso prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, laddove il minore non abbia almeno 16 anni. L’art. 17 prosegue, precisando che il diritto alla cancellazione non trova applicazione, invece, se il trattamento oggetto di cancellazione è necessario (art. 17 c. 3 del GDPR).
Tale limitazione del diritto all’oblio e/o cancellazione, così come configurato dal legislatore comunitario, si ha quando la raccolta dei dati attiene all’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione o all’adempimento di un obbligo legale, che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, cui è soggetto il titolare del trattamento. Ulteriori casi di limitazione del diritto si hanno quando la raccolta dei dati attiene all’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri, di cui è investito il titolare del trattamento, o per motivi di interesse pubblico, nel settore della sanità pubblica, o per fini di archiviazione, nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o, ancora, a fini statistici e, infine, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Appare, a questo punto, opportuno soffermarsi su alcuni ulteriori profili che attengono al diritto all’oblio e alla nuova normativa europea sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). Un primo aspetto da analizzare attiene alla modalità di esercizio del diritto all’oblio, come delineato dal GDPR, infatti, la pretesa cancellazione dei dati da parte dell’interessato al trattamento è una conseguenza del verificarsi di una delle situazioni previste dal citato art. 17 c. 1 del GDPR, non è, quindi, necessario l’esercizio diretto di una richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. L’azienda (titolare del trattamento) deve procedere spontaneamente e automaticamente alla cancellazione dei dati personali che riguardano un individuo, qualora si verifica una delle situazioni elencate nell’art. 17 c. 1 del GDPR, a prescindere, infatti, dall’esercizio del diritto da parte dell’interessato. L’interessato ha, in ogni caso, sempre facoltà di procede con una richiesta espressa di cancellazione, nelle forme libere che ritiene opportune, se il titolare non ne ha predisposte appositamente.
La cancellazione deve essere effettuata senza giustificato ritardo (entro un mese previsto per il riscontro) e deve a titolo gratuito, anche se l’azienda titolare può prevedere un ragionevole contributo spese o rifiutarsi se dimostra che la richiesta è manifestamente infondata o eccessiva, in particolare, se ripetuta nel tempo. Al verificarsi di uno degli eventi previsti dall’art. 17 c. 1, quindi, in caso di richiesta di cancellazione di dati personali, ogni azienda dovrebbe valutare l’applicabilità del diritto, coinvolgendo diversi soggetti. E’ opportuno evidenziare che l’art. 59 del GDPR stabilisce che il titolare deve prevedere modalità volte ad agevolare l’esercizio dei diritti da parte degli interessati, per cui, sarebbe opportuno che l’azienda titolare attuasse un processo implicante almeno un referente legale, per valutare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto alla cancellazione (es. valutare se sussista il caso di accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o il caso di trattamento illecito) e di un referente IT, per valutare gli aspetti tecnici relativi alla cancellazione. Sarebbe opportuno, altresì, individuare dei referenti privacy interni, che si occupassero della cancellazione, in caso di trattamenti effettuati esclusivamente in forma cartacea (es. Funzione Customer Service per richieste dei clienti, Funzione HR per quelle dei dipendenti, Ufficio Acquisti per terze parti). Al termine della valutazione da parte dei suddetti soggetti, se il diritto alla cancellazione non dovesse essere ritenuto applicabile, l’azienda titolare dovrebbe notificare l’esito della valutazione all’interessato. Laddove, invece, il diritto alla cancellazione venisse ritenuto applicabile, gli stessi soggetti dovrebbero eseguire le operazioni tecniche di cancellazione e dovrebbero informare dell’avvenuta cancellazione l’interessato.
In alternativa alla cancellazione, l’azienda titolare potrebbe propendere per l’anonimizzazione dei dati, purché eseguita correttamente, ossia senza possibilità di re-identificazione dell’interessato. Non sarebbe, invece, sufficiente la semplice pseudonimizzazione. L’azienda titolare, infine, dovrebbe organizzarsi per provvedere a comunicare la cancellazione a ciascuno dei destinatari ai quali sono stati trasmessi i dati personali dell’interessato (ivi compresi contitolari e responsabili), salvo che ciò si rivelasse impossibile o implicasse uno sforzo sproporzionato. Da quanto innanzi, si comprende che il diritto all’oblio va valutato caso per caso, considerando, altresì, che tale esigenza è maggiormente avvertita, ove si rapporti il diritto all’oblio a quello di cronaca. Il diritto di cronaca, infatti, per pacifica e risalente acquisizione giurisprudenziale, è un diritto pubblico che trova il proprio fondamento nella previsione dell’art. 21 Cost., che sancisce il principio della libera manifestazione del pensiero e della libertà di stampa.
Tale diritto d’informazione non è scevro da limiti, infatti, affinché possa essere legittimamente esercitato, devono necessariamente sussistere tre condizioni: l’utilità sociale dell’informazione, la veridicità e il rispetto della dignità delle persone. Il diritto all’oblio è collegato al diritto di cronaca, infatti, lo stesso acquista efficacia quando non vi è più un apprezzabile interesse pubblico o la notizia è falsata, in quanto non aggiornata o l’esposizione dei fatti non sia stata commisurata all’esigenza informativa ed abbia arrecato un danno alla dignità dell’interessato. Orbene, tracciare i confini di un concreto bilanciamento tra contrapposti valori costituzionali, quali quello del diritto all’informazione ex art. 21 Cost. e quello del diritto alla riservatezza ex art. 2 Cost., ben si comprende, non è sempre agevole. La giurisprudenza italiana ha avuto modo di pronunciarsi su tale tematica con la sentenza del 9 aprile del 1998 n. 3679, con la quale si è evidenziato l’emergere di un nuovo profilo relativo alla riservatezza: il diritto all’oblio, inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indefinitamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata. Tale pronuncia ha con chiarezza statuto il diritto della persona a che certe notizie non vengono ulteriormente diffuse, a distanza di tempo.
La difficoltà a bilanciare tali importanti contrapposti valori non ha trovato un’organica soluzione anche nelle diverse pronunce della Suprema Corte, che è stata chiamata a pronunciarsi negli anni (9 giugno del 1998 n.5658, 24 aprile 2008 n.10690, 5 aprile 2012 n. 5525, 26 giugno 2013 n. 16111, sentenza 22 giugno 2017) su specifici aspetti, e ciò anche tenendo in considerazione alcune pronunce emesse dalle Corti europee. Meritano di essere menzionate la sentenza 13 maggio 2014 della Corte di Giustizia dell’Unione Europera, relativa al procedimento Google Spaim n.131/12 o la sentenza del 19 ottobre 2017 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Recentemente la Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi, con la sentenza del 22 luglio del 2019 n.19681, con la quale ha statuito che il giudice di merito ha il compito di valutare la sussistenza dell’attualità dell’interesse pubblico, al fine di bilanciare il diritto di cronaca con quello all’oblio e, quindi, ai fini della rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi passati che rientrano nell’ambito della “cronaca” e non della “storia” da intendersi come rievocazione di fatti ed eventi che hanno segnato la vita di una collettività e che, quindi, fa parte della storia di un popolo.
Ne consegue che prevale il diritto alla riservatezza, quando non sussiste più un interesse pubblico e si sia spenta la memoria collettiva. Tale sentenza, anche se conferma quanto acquisito dalla giurisprudenza, cioè che il bilanciamento innanzi trattato deve essere analizzato caso per caso dal giudice di merito, rende ancor più evidente che il diritto all’oblio non ha di per sé, né può avere, un contenuto univoco e che, pertanto, la sua applicazione richiede, altresì, un’attenta ed approfondita indagine dei fatti e del tempo intercorso dal verificarsi degli stessi.
Avv. Raffaele Antonio Nacchia – Tesoriere della Camera Civile di Nocera Inferiore